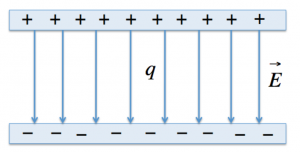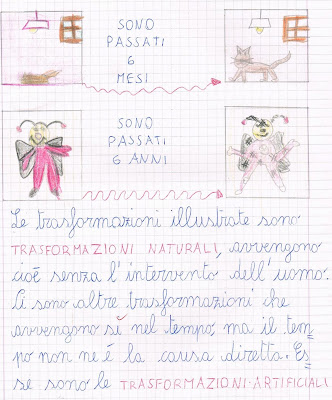Chattando con una mia amica stamattina, seduta lì davanti al pc dall’altra parte dell’oceano, mi sono accorta di quanto stiano passando in fretta i giorni, le settimane, le stagioni. “Da quanto tempo sei lì allora?” “Boh, saranno cinque mesi” “Cinque mesi? Controlla meglio il calendario, cara.” Fu così che mi resi conto che sono davvero trascorsi otto mesi. OTTO mesi, signore e signori. E siamo già arrivati a Natale. Non mi sembra vero.
 Sebbene mi sia trasferita per lavoro, per qualcosa che tra l’altro mi appassiona tantissimo e che mi impegna più di 10 ore al giorno, spesso mi sembra di essere in vacanza e di trovarmi qui per curiosare, annotare, annusare e allegramente perplimermi di tutto quello che mi circonda. Alice nel paese delle meraviglie ha fatto il suo tempo ormai, ma il momento di disincanto non mi è ancora passato.
Sebbene mi sia trasferita per lavoro, per qualcosa che tra l’altro mi appassiona tantissimo e che mi impegna più di 10 ore al giorno, spesso mi sembra di essere in vacanza e di trovarmi qui per curiosare, annotare, annusare e allegramente perplimermi di tutto quello che mi circonda. Alice nel paese delle meraviglie ha fatto il suo tempo ormai, ma il momento di disincanto non mi è ancora passato.
Quando abbiamo deciso di accettare quella proposta di trasferimento avevo il sentore che sarebbe stato un periodo da luna park e da ottovolante, ma non avrei mai pensato che le mie paure si sarebbero dissolte così in fretta. Perché io avevo paura, davvero. Una paura matta. Come quando ero bambina. Salivo i tre gradini della scalinata e mi buttavo nelle braccia di mio padre. “Buttati, non avere paura”. Tre secondi di indecisione, occhi chiusi per due secondi, quello strano sfarfallio nello stomaco e poi via… si salta. Ad occhi bene aperti.
Mi capita di tanto in tanto di alzarmi nel cuore della notte, e di ritrovarmi a piedi nudi davanti alla finestra del salotto a fissare il paesaggio. Una sfilza di casette con il tetto in stile New England, nel buio solo gli ingressi illuminati. Quel tetto piovente che associavo alla “casa” per eccellenza nei miei scarabocchi di bambina, un tetto di tegole, col comignolo in bella vista. E’ la seconda volta nel giro di 10 minuti che nomino me stessa bambina e mi chiedo il perché. In quei momenti di sospensione, nei quali esco dalla frenesia della vita di tutti i giorni, dal sovrappensiero del quotidiano, mi sembra di vivere in un film. Il fatto di abitare in un posto che sembra il set di Desperate Housewives non aiuta. Poi tutto riprende al ritmo consueto e non ci penso più.
Eppure questi momenti al rallentatore ritornano, di tanto in tanto. A volte diventano dei fermo immagine. Ogni mattina di fronte al lettone e ogni pomeriggio accanto alla mia scrivania ritrovo questo cielo e queste nuvole. Ogni giorno andando a lavoro me le ritrovo sulla testa. Sono felice di aver fatto la scelta di cercare casa a qualche chilometro da Boston e non in pieno centro cittadino. A parte il lato economico (appena vinco la lotteria magari un appartamento in centro me lo cerco, adesso preferisco passare, grazie) in questo modo possiamo evitare di fare la vita dei commuters e guidare per 40 minuti ogni mattina e ogni sera (cosa che odio) e goderci di più la città durante i weekend. E’ bello perché riesco a godere di entrambi i paesaggi, quello metropolitano con i palazzi altissimi, le strade brulicanti di gente, le luci, e quello più suburbano, fatto di casette tipiche, di laghetti e di diners dove ti puoi fermare a prendere uno di quei beveroni scuri che si ostinano a chiamare “caffè americano”.
I primi due mesi sono stati davvero un turbinio di giri frenetici tra documenti da fare, fogli da firmare, persone da  incontrare. Poi passa un po’ di tempo e ti accorgi che hai finalmente il tuo social security number e ridacchi sotto i baffi pensando al fatto che ormai sei ufficialmente un resident alien, termine bizzarro che ti fa sentire un po’ come E.T. Ti accorgi di tante cose che da fuori ovviamente non puoi notare. Prima di tutto, lo yankee lo riconosci subito. E’ unico il suo gusto fine in materia di abbigliamento. Un gusto che lo porta ad indossare il pantalone del pigiama mentre va a fare la spesa al supermercato e a giudicare il tuo vestitino preso sui saldi di Asos per 8 euro un abito “sofisticato”. Ma, detto questo, è dunque Egli una razza in via di estinzione? Lo yankee esiste ancora? E soprattutto, è davvero così difficile farsi comprendere da codesti esseri? Perché deve essere ben chiaro. Non basta essersi sorbite 5 anni anni di liceo linguistico e 4 anni di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Non basta essersi laureate in Traduzione Letteraria dall’Inglese all’Italiano con una tesi sui racconti di un semi-oscuro autore scozzese (a proposito, se a qualcuno interessa ve la mando, magari trovo qualcuno disposto a pubblicarmela). Non basta aver visto tutti i film e tutti i serial preferiti in lingua originale per anni e anni e anni. Non basta. Arrivi qui e ti ritrovi a balbettare come una scolaretta. Una semplice domanda fatta dal bancone di un Mac Donalds (“Stay or go?” ma detto a velocità della luce, eh!) può provocare genti disperati e fughe improvvise. Poi però la situazione migliora.
incontrare. Poi passa un po’ di tempo e ti accorgi che hai finalmente il tuo social security number e ridacchi sotto i baffi pensando al fatto che ormai sei ufficialmente un resident alien, termine bizzarro che ti fa sentire un po’ come E.T. Ti accorgi di tante cose che da fuori ovviamente non puoi notare. Prima di tutto, lo yankee lo riconosci subito. E’ unico il suo gusto fine in materia di abbigliamento. Un gusto che lo porta ad indossare il pantalone del pigiama mentre va a fare la spesa al supermercato e a giudicare il tuo vestitino preso sui saldi di Asos per 8 euro un abito “sofisticato”. Ma, detto questo, è dunque Egli una razza in via di estinzione? Lo yankee esiste ancora? E soprattutto, è davvero così difficile farsi comprendere da codesti esseri? Perché deve essere ben chiaro. Non basta essersi sorbite 5 anni anni di liceo linguistico e 4 anni di Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Non basta essersi laureate in Traduzione Letteraria dall’Inglese all’Italiano con una tesi sui racconti di un semi-oscuro autore scozzese (a proposito, se a qualcuno interessa ve la mando, magari trovo qualcuno disposto a pubblicarmela). Non basta aver visto tutti i film e tutti i serial preferiti in lingua originale per anni e anni e anni. Non basta. Arrivi qui e ti ritrovi a balbettare come una scolaretta. Una semplice domanda fatta dal bancone di un Mac Donalds (“Stay or go?” ma detto a velocità della luce, eh!) può provocare genti disperati e fughe improvvise. Poi però la situazione migliora.
Dopo essere sopravvissuta a meeting di due ore che potevano riassumersi a mò di barzelletta (“C’erano un australiano cresciuto in Finlandia, un colombiano che parla svedese, un inglese sposato con una cinese, un brasiliano amante della pizza e due italiani agitati che discutevano sull’argomento del giorno”), dove ovviamente ognuno dei presenti parlava con un accento diverso, ho capito che la pronuncia da Oxford qui non la cerca nessuno, e magari fa pure paura. Dopo aver superato la paura di comunicare e il cupo terrore di fare brutte figure e aver sostenuto piacevoli conversazioni telefoniche al limite della macchietta (amici francesi perdonatemi, ma avete  una cadenza agghiacciante), sono giunta alla conclusione che parlare inglese, o meglio esprimersi in inglese, e davanti ad americani, è facile, basta farsi capire. In qualsiasi modo lecito. Se poi non comprendono le parole puoi sempre farti aiutare dai gesti, e in questo da brava italiana non sono seconda a nessuno. Proprio per questo sulla mia scrivania campeggia codesto poster, che funziona perfettamente da conversational piece, come dicono qui. Insomma, ci siamo ambientati bene, per la gioia di mia mamma che ogni settimana su Skype mi chiede “Cosa combinano questi americani? E salutami tanto Obama, mi raccomando!” E si sono ambientate bene anche le due mie caviotte, che si sono sorbite quasi dieci ore in totale di volo più file e sfilate varie di fronte a diversi sportelli, e per questa ragione le adoro ancora di più. Anche se a dire il vero su quell’aereo loro due erano le più rilassate.
una cadenza agghiacciante), sono giunta alla conclusione che parlare inglese, o meglio esprimersi in inglese, e davanti ad americani, è facile, basta farsi capire. In qualsiasi modo lecito. Se poi non comprendono le parole puoi sempre farti aiutare dai gesti, e in questo da brava italiana non sono seconda a nessuno. Proprio per questo sulla mia scrivania campeggia codesto poster, che funziona perfettamente da conversational piece, come dicono qui. Insomma, ci siamo ambientati bene, per la gioia di mia mamma che ogni settimana su Skype mi chiede “Cosa combinano questi americani? E salutami tanto Obama, mi raccomando!” E si sono ambientate bene anche le due mie caviotte, che si sono sorbite quasi dieci ore in totale di volo più file e sfilate varie di fronte a diversi sportelli, e per questa ragione le adoro ancora di più. Anche se a dire il vero su quell’aereo loro due erano le più rilassate.
******
I meno distratti di voi si saranno accorti che per Natale mi sono regala un dominio e un header nuovo, ma è ancora tutto under construction e ho intenzione di dedicare al mio blog tutta l’attenzione che si merita e che finalmente riesco a dargli.
Sarà un bagno di sangue perché il tempo è sempre tiranno e sarò costretta come sempre ad aggiornarlo di notte e nei ritagli di tempo, ma quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Si dice così? Ho in mente diverse cosette e argomenti da seguire: voglio parlare di tutto ciò che vedo di interessante, e in questi mesi di cose ne ho viste moltissime, i miei archivi stanno esplodendo; voglio finalmente portare a termine un paio di progetti fotografici che avevo iniziato in Italia e che si erano arenati dopo il trasloco; voglio continuare con i miei articoli e le mie interviste; voglio finalmente postare pagine e pagine scritte a matita sulla mia Moleskine, e che continuo senza sosta a riscrivere nella mia testa, parole che per me sono importanti; vorrei anche iniziare un paio di rubriche fotografiche, una magari anche imperniata su Instagram. Però ci vuole tempo, tempo e impegno.
A proposito, il progetto per Vogue Encyclo va avanti, e l’ultimo articolo su Mark Seliger lo trovate qui. E la mia visita all’ICA di Boston si è trasformata in una recensione per Makemehappytoday qui.
Archiviato in:Boston Chronicles, Life, Pensieri sparsi Tagged: Blog, makemehappytoday, nuvole, parole, paure, pensieri, progetti, trasloco, vogue encyclo